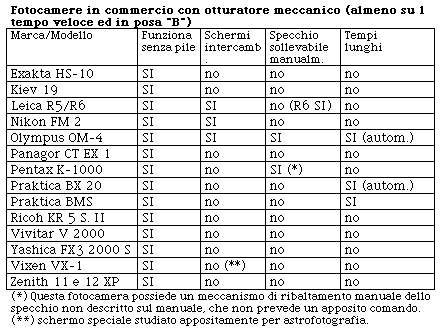
Ecco una serie di criteri per effettuare la scelta della macchina fotografica più adatta per gli appassionati di fotografia astronomica.
Ma l'astrofotografo, nonostante i passi avanti della tecnologia, non può fare a meno di utilizzare una comune macchina fotografica per la ripresa degli amati oggetti astronomici. Queste note si propongono di fare il punto sulle caratteristiche che dovrebbe possedere la macchina fotografica ideale per l'uso astrofotografico, confrontandole successivamente con i modelli che offre il mercato.
Le pellicole medio formato o 120 (e il 220, che è identico al 120 ma è privo della protezione di carta per consentire il bobinamento di rullini più lunghi) sono caratterizzate da un supporto privo di perforazione con una larghezza di 70 mm, che consente l'impressione di fotogrammi formato 6x4.5 cm, 6x6 cm, 6x7 cm fino ai 6x17 cm di alcune macchine panoramiche.
Come detto, il formato più usato è il 135, perchè consente la costruzione di macchine e obiettivi di dimensioni e pesi più contenuti a prezzi più accessibili. Lo scotto dell'uso del formato 135 rispetto al 120 è la minore superficie del fotogramma e la conseguente necessità di ingrandire la negativa più di quanto non sia necessario con il formato maggiore, con conseguente scadimento della qualità delle immagini.
Le fotocamere reflex hanno una struttura molto complessa e si compongono principalmente di due parti: il corpo macchina e l'obiettivo, unite tra loro tramite un innesto a vite o a baionetta, meccanicamente differenti a seconda della marca della fotocamera. Il fotografo può togliere l'obiettivo semplicemente agendo su un meccanismo di sblocco ed effettuando una parziale rotazione della montatura dell'obiettivo. Gli obiettivi delle moderne reflex 35mm sono intercambiabili liberamente. Il corpo macchina, sistemato all'interno di uno chassis metallico, si compone di un dorso portapellicola, di un otturatore, di una scatola dello specchio, di uno schermo di messa a fuoco, di un pentaprisma e di un oculare.
Altre parti accessorie sono l'esposimetro incorporato, la leva di caricamento dell'otturatore e di avanzamento della pellicola (o l'eventuale motore), varie parti elettriche e/o elettroniche, ed un vano porta-batterie.
Le prime funzionano con meccanismi simili a quelli degli orologi, basati su ingranaggi, molle, ecc. e funzionano anche senza pile. Il funzionamento di queste fotocamere è in genere buono, pur richiedendo una manutenzione periodica. La qualità delle prestazioni di questo tipo di macchine dipende in grande misura dalla qualità del progetto, dei materiali, della marca e dal modello, che si traduce nel prezzo richiesto per il loro acquisto. Come vedremo più avanti, oggigiorno il mercato non offre più molti modelli di fotocamera meccanica, ed è spesso necessario cercare alcuni modelli particolarmente interessanti sul mercato dell'usato.
Le reflex elettroniche sono molto più sofisticate ed offrono un funzionamento più preciso, molte funzioni automatizzate (variabili da modello a modello) ed un design molto più attuale e accattivante. Sono però totalmente asservite alle pile e questo fattore si rivela, per l'astrofotografo, cruciale e molto penalizzante.
Infatti nell'astrofotografia a lunga esposizione si richiede che l'otturatore rimanga aperto per lunghi periodi. Durante le pose astrofotografiche l'otturatore di tipo elettronico consuma la corrente delle pile, scaricandosi in breve tempo (in media qualche ora) anche se rimane immobile. Inoltre una fotocamera elettronica mal sopporta le basse temperature, piuttosto frequenti in montagna d'inverno, e può giungere a bloccarsi se si scende sotto i -5°C.
Le macchine fotografiche meccaniche non consumano corrente durante le lunghe esposizioni in posa B o T, ed in genere funzionano bene anche a temperature estreme.
Reflex 35 mm con pentaprisma fisso, schermo di messa a fuoco fisso a lente di Fresnel, con telemetro ad immagine spezzata al centro e corona di microprismi, otturatore elettronico a tendina con tempi di esposizione regolabili da 1/1000 di secondo ad 1 secondo + posa B, esposimetro interno al silicio con misurazione della luce di tipo medio compensata al centro, esposizione manuale ed automatica con priorità ai diaframmi, innesto per obiettivo a baionetta, obiettivo focale 50 mm f/1.8. Avanzamento della pellicola manuale con leva di carica o motorizzato. Dorso portapellicola fisso. Specchietto non sollevabile manualmente.
La parte poco interessante per gli usi astrofotografici è quella che riguarda l'esposimetro ed i dispositivi per la misura della luminosità e la relativa scelta dei tempi di esposizione e dei diaframmi. Infatti in astrofotografia non si usa l'esposimetro salvo che - talvolta - nella ripresa del Sole e della Luna.
L'unica caratteristica di questo tipo che la fotocamera per astrofotografia DEVE possedere è l'impostazione manuale dei tempi e dei diaframmi. Tutte le altre caratteristiche sono invece interessanti per l'astrofotografo. Analizziamole brevemente una ad una: Il pentaprisma di alcune fotocamere è intercambiabile, per consentire il montaggio di altri tipi di mirino, come quello a pozzetto o di ingrandimento (con visione dall'alto, molto comoda quando viene usata con telescopi a fuoco posteriore come i rifrattori, o i Cassegrain), o dotati di dispositivi speciali di misurazione della luce. La stragrande maggioranza delle reflex 35mm hanno però il pentaprisma fisso.
Lo schermo di messa a fuoco è molto importante: si tratta di una lastrina di vetro o di materiale plastico sistemata sopra allo specchio reflex, su cui si forma l'immagine che il fotografo vede nel mirino. Questa lastrina normalmente è smerigliata per aumentare la precisione di messa a fuoco, ed al centro è dotata di altri due dispositivi ottici che aiutano ad ottenere una fuocheggiatura più precisa con obiettivi di corta focale. Usato con il telescopio, uno schermo standard di messa a fuoco dimostra molti limiti: il telemetro ad immagine spezzata diventa nero per la bassa luminosità del telescopio, la corona di microprismi si dimostra utile solo con soggetti di grandi dimensioni angolari e la smerigliatura del vetrino è molto scura e non consente di vedere i soggetti poco luminosi.
Pertanto nelle tipiche condizioni della fotografia astronomica la messa a fuoco diventa molto difficile salvo che sul Sole, sulla Luna e sui pianeti più luminosi. Quando i soggetti sono molto deboli - come nel caso di nebulose, ammassi stellari, galassie - nel mirino si vede poco o nulla.
Alcune fotocamere consentono la sostituzione dello schermo di messa a fuoco con altri tipi di schermo, alcuni dei quali pubblicizzati come espressamente dedicati alle riprese astronomiche. Si tratta in generale di schermi con smerigliatura più fine, o totalmente trasparenti o ancora con scale graduate o reticoli incisi. Questi schermi consentono effettivamente di vedere nel mirino qualcosa di più di quanto si veda con gli schermi standard, ma sono di poco aiuto durante le operazioni di messa a fuoco con il telescopio a meno che non siano usati assieme ad altri accessori come i mirini ingranditori.
Dell'otturatore si è già detto, almeno per quanto riguarda il consumo di corrente. Bisogna aggiungere che nella fotografia planetaria si utilizzano tempi di esposizione non superiori alla trentina di secondi, e può essere apprezzabile un otturatore che consenta l'impostazione di tempi di posa lunga (superiori al secondo, oltre alla posa "B").
Lo scatto dell'otturatore provoca una vibrazione, tanto meno avvertibile quanto minore è la massa delle tendine di cui è costituito e quanto maggiore è la loro velocità di scorrimento. Normalmente le tendine dell'otturatore sono costruite in stoffa gommata, alluminio indurito o titanio. La velocità delle tendine può raggiungere i 10 metri al secondo per gli otturatori in titanio. In ogni caso l'effetto della vibrazione è modesto rispetto a quello indotto dal sollevamento dello specchietto.
Il tipo di innesto per gli obiettivi è quasi sempre diverso da marca a marca, ma i produttori di accessori per telescopi offrono anelli di tutti i tipi, sia a vite che a baionetta, per adattare le fotocamere ai raccordi standard per telescopio, universalmente dotati di filettatura diametro 42 mm e passo metrico 0,75 mm (conosciuta come passo T-2). Sono disponibili anelli T-2 anche per fotocamere di marche uscite da anni dal mercato come Topcon e Contarex, oppure per modelli inadatti alla fotografia astronomica come le modernissime super-elettroniche autofocus (con messa a fuoco automatica). L'unica caratteristica irrinunciabile è la fotocamera sia ad ottica intercambiabile, cioè che sia possibile rimuovere l'obiettivo.
Il meccanismo di avanzamento della pellicola, che si incarica anche si armare l'otturatore della fotocamera, può essere a leva manuale oppure motorizzato. La presenza del motore, utile in alcuni casi, non pregiudica l'uso astrofotografico, ma provoca vibrazioni (anche se dopo lo scatto) e naturalmente consuma la corrente delle pile. Pertanto il motore è da considerare un gadget poco utile per l'astrofotografia.
Parlando di avanzamento della pellicola, non bisogna dimenticare di citare il contapose, dispositivo che si incarica di conteggiare le foto già scattate. In realtà il contapose della maggioranza delle fotocamere si occupa di conteggiare gli scatti dell'otturatore, e non tiene assolutamente del reale scorrimento della pellicola. Potrebbe capitare che si scattino foto per un'intera nottata salvo accorgersi alla fine che la pellicola non è stata agganciata dal meccanismo di trascinamento. Alcune macchine meccaniche (e molte delle elettroniche) sono dotate di un utilissimo segnalatore che indica il regolare aggancio e scorrimento della pellicola.
All'interno del dorso portapellicola si trova il rocchetto che accetta il terminale, detto coda, del rullino di pellicola, con un meccanismo studiato per facilitarne l'inserimento. Questo meccanismo è spesso realizzato in modo un po' cervellotico, e può essere causa di problemi di aggancio. Consigliamo di curare molto bene l'aggancio della pellicola per evitare che si verifichino gli inconvenienti già citati.
Solo un modello di reflex 35 mm consente la sostituzione dell'intero dorso o magazzino portapellicola (la poco diffusa Rolleiflex 3003), mentre questa caratteristica è normale per le fotocamere del medio formato. L'intercambiabilità del dorso è tutt'altro che inutile, perchè consente al fotografo di utilizzare nella stessa serata una sola fotocamera con più tipi di pellicola anche scattando un solo fotogramma per ciascun tipo. Sarebbe infatti sufficiente sostituire il magazzino di volta in volta. Ma la complessità meccanica insita in questa utile caratteristica (ed i relativi costi) ha consigliato i fabbricanti a non prenderla in considerazione.
Parliamo infine dello specchietto, il cui sollevamento al momento dello scatto è la causa principale delle dannose vibrazioni che la fotocamera trasmette al telescopio, provocando un mosso che si traduce in una minore nitidezza. Questo effetto è tanto più grave quanto maggiore è la focale impiegata e fa quindi sentire i suoi effetti soprattutto quando si fotografano i pianeti o le stelle doppie con la tecnica della proiezione dell'oculare. La maggioranza delle reflex in commercio non consente il ribaltamento manuale dello specchietto prima dello scatto, caratteristica che sarebbe invece molto utile per prevenire le vibrazioni.
Le tre fotocamere reperibili sul mercato che rispondono a tutte le caratteristiche elencate sono MOLTO costose:
(*) rilevamento 1992
Se però ci si accontenta di solo alcune delle caratteristiche ideali, si trovano parecchie fotocamere a prezzi più accessibili. La tabella che segue elenca alcune reflex 35 mm dotate di otturatore meccanico (almeno in posa B o T). Nessuno dei modelli elencati ha il mirino intercambiabile.
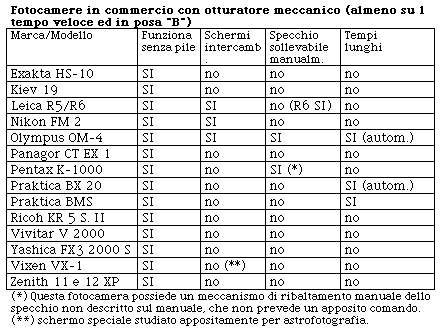
Considerando però che molte fotocamere non-autofocus con otturatore elettronico possono garantire un buon funzionamento nella fotografia a breve e media esposizione ed a temperature non rigide, forniamo un breve elenco di modelli elettronici ma dotati di alcune caratteristiche positive per le riprese astronomiche.
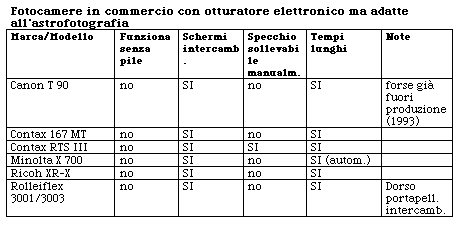
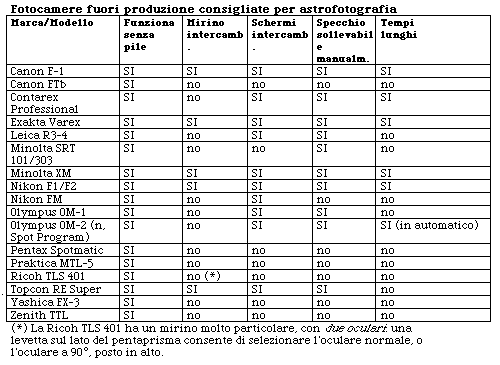
Nota: se volete acquistare una fotocamera fuori produzione trovata sul mercato dell'usato, compratela completa degli accessori, oppure controllate in vari negozi o sulle riviste specializzate se essi sono ancora reperibili. Non ha infatti senso acquistare un corpo macchina che - per esempio - consente la sostituzione degli schermi di messa a fuoco se poi questi sono introvabili.
E' utile l'autofocus per gli usi astronomici? La risposta è no, anche perchè i dispositivi autofocus si basano sulla movimentazione delle lenti negli obiettivi a loro dedicati, che nel tipico uso astronomico vengono rimossi per consentire l'adattamento del corpo macchina al telescopio.
Una macchina autofocus priva di obiettivo non smette però di funzionare, e si comporta come una normale macchina elettronica. E' quindi utilizzabile anche per l'astrofotografia. Queste macchine offrono una funzione in più delle normali macchine elettroniche: nel mirino viene segnalato se il soggetto inquadrato è a fuoco o meno (se la luce è sufficiente). Questa funzione, detta messa a fuoco assistita, potrebbe rivelarsi utile con Sole, Luna e pianeti.
Inoltre tutte le macchine autofocus sono dotate di un display digitale a cristalli liquidi esterno, che riporta il numero delle pose, il tempo di esposizione impostato, lo stato di carica delle batterie ed altri dati utili. La consultazione dei dati esposimetrici su questi display è molto comoda e rapida.
Gli svantaggi di queste fotocamere sono il peso, l'ingombro, il costo elevato. Inoltre la grande massa dello specchio reflex rende lo scatto rumoroso e generatore di forti vibrazioni.
I vantaggi sono: la vasta disponibilità di accessori professionali, la possibilità di sfruttare il grande campo illuminato di alcuni telescopi di alta qualità, grande diametro o grande campo corretto (i rifrattori apocromatici, i riflettori Ritchey-Chretien, le Baker-Schmidt, alcuni catadiottrici speciali). Inoltre la maggiore dimensione del fotogramma necessita di un minore ingrandimento in fase di stampa, con conseguente aumento della nitidezza delle immagini.
Queste fotocamere forniscono immagini eccezionali se utilizzate con i loro obiettivi originali nella cosiddetta fotografia in parallelo al telescopio o su inseguitore automatico.
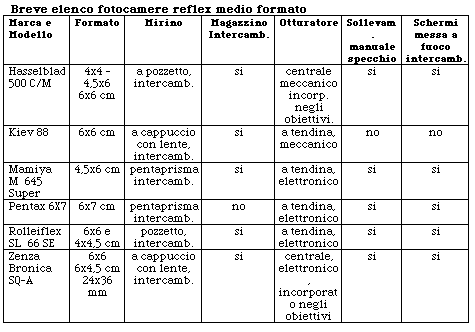
La Taurus è essenzialmente un dorso porta-pellicola con otturatore manuale (magnetico), trascinamento pellicola manuale, peso ultra-leggero, tiraggio bassissimo. La messa a fuoco viene eseguita con un adattatore in cui va inserito un oculare (la cui posizione deve essere tarata), da posizionare proprio sul piano focale.
La TAURUS technologies offre una serie di accessori adattabili alla fotocamera base, dei quali il più importante è il Tracker (dispositivo per l'inseguimento), che fa le funzioni di dispositivo di puntamento, messa a fuoco e guida fuori asse, utilizzando un sistema di specchietti ribaltabili.
L'accoppiamento meccanico tra la camera Taurus e gli accessori è ottenuto per mezzo di magneti. Oltre che utile, questa camera è anche piuttosto economica. La camera base costa solo 130 dollari. L'intero sistema, completo di camera, tracker, lente di barlow speciale, dispositivo di messa a fuoco, portafiltri, ecc., costa 330 dollari. Spese bancarie e di spedizione, IVA, e dazio esclusi, naturalmente.