La postazione equatoriale
Questa importantissima operazione è necessaria per consentire al telescopio ed al suo moto orario di inseguire con precisione il moto apparente degli oggetti celesti durante le lunghe pose.
La postazione deve essere eseguita con telescopi dotati di montatura equatoriale, che sono gli unici adatti alla ripresa fotografica a lunga esposizione degli oggetti del profondo cielo.
I telescopi computerizzati altazimutali, recentemente comparsi sul mercato internazionale, che puntano ed inseguono con precisione questi oggetti, non sono idonei a questo tipo di fotografia, salvo che non vengano anch'essi montati in configurazione equatoriale.
Infatti un telescopio in configurazione altazimutale insegue il cielo ma non può impedire che il campo inquadrato dal telescopio ruoti, producendo foto a lunga esposizione ben inseguite al centro ma "strisciate" ai bordi.
I metodi
Esistono vari metodi per effettuare la postazione equatoriale di un telescopio, che differiscono tra loro per grado di semplicità e di precisione.
Non sempre un metodo semplice e rapido è anche impreciso, come dimostra il caso dell'uso del cannocchiale polare.
E' chiaro che il metodo prescelto dipenderà dal grado di precisione che si vuole ottenere ed anche dal tempo che si ha a disposizione.
Infatti il più delle volte la fotografia al profondo cielo viene praticata con telescopi portatili con la formula del "vado (in montagna, o comunque in un luogo con un bel cielo), monto tutto, fotografo, smonto e torno", tutto in una notte.
In queste condizioni, un metodo rigoroso e precisissimo come quello della deriva in declinazione porterebbe via più di un'ora e sarebbe quasi inaccettabile.
Per fortuna molti telescopi moderni sono dotati di serie di alcuni utili accessori come il cercatore con reticolo polare o il cannocchiale polare che aiutano l'astrofilo ad ottenere in tempi rapidi una postazione soddisfacente.
Se al contrario non si dispone di nulla più di un telescopio con dotazione normale, occorrerà ingegnarsi.
NOTA: per ottenere buoni risultati con i metodi descritti qui di seguito è necessario accertarsi che il cerchio graduato di declinazione sia ben regolato, e che i due assi di Ascensione Retta e Declinazione siano perfettamente perpendicolari tra loro.
Sarà utile (anche se non indispensabile) mettere perfettamente in "bolla" il treppiede o la colonna del telescopio per fare in modo che i moti micrometrici che agiscono sul puntamento dell'asse polare corrispondano in modo preciso al movimento in altezza ed al movimento in azimut, senza ambiguità.
Nozioni fondamentali
La stella polare non coincide con il Polo Celeste vero, ma ne dista attualmente circa 50', cioè poco meno di un grado. A causa della precessione degli equinozi e della combinazione dei vari moti propri, questa distanza tende a crescere progressivamente con gli anni, come evidenziato nella cartina qui sotto:
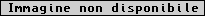 (figura X).
(figura X).
Per trovare il polo vero usando la cartina:
verificate che il cercatore e il telescopio siano perfettamente allineati tra loro
ruotate il tubo del telescopio fino a renderlo esattamente parallelo all'asse orario della montatura equatoriale (sul cerchio di declinazione dovrete leggere il valore di 90 gradi)
rivolgete il telescopio verso il nord ed usando esclusivamente i moti di inclinazione ed orientazione dell'asse orario, centrate la stella polare nel cercatore
osservando la cartina, centrate il reticolo del cercatore sul polo vero
Metodo delle coordinate della stella polare
Se possedete dei cerchi graduati molto precisi, è sufficiente determinare l'ora siderale locale, puntare il telescopio (con il tubo reso parallelo all'asse orario - vedi paragrafo precedente) verso il Meridiano locale, impostare l'ora siderale sul cerchio graduato di ascensione retta (l'ora siderale locale viene definita come l'ascensione retta delle stelle che stanno culminando in quel momento al Meridiano locale) e poi puntare il telescopio sulle coordinate della stella polare (A.R.2h 23' 39", DEC 89B0 13' 11"- Eq.1993.0).
Naturalmente la stella polare non risulterà puntata nel telescopio, ma a questo punto sarà sufficiente inquadrarla al centro del campo del telescopio usando solo i moti di regolazione in azimuth ed in altezza dell'asse polare (NON bisogna usare i movimenti di A.R. e declinazione in questa fase!).
Quando la polare è al centro del campo del telescopio principale, il gioco è fatto!
Ripetete per 2-3 volte questo procedimento si aumenterà la precisione di allineamento, che comunque non sarà migliore di una decina di primi d'arco.
Per verificare la precisione sarà necessario utilizzare il metodo della deriva in declinazione.
Metodo della deriva in declinazione
E' di gran lunga il metodo più preciso per ottenere la postazione equatoriale, ma è anche molto lungo ed impegnativo.
E' necessario utilizzare un oculare con reticolo illuminato che offra una visione totalmente capovolta (piena visione telescopica). Nel caso che si interpongano prismi o specchi deviatori occorrerà tenerne conto.
Dopo avere ottenuto una postazione approssimativa con uno dei metodi descritti in precedenza o anche solo puntando semplicemente la polare nel cercatore (sempre con i soli moti in azimut e altezza), si deve procedere come segue:
Al termine di queste operazioni, la montatura del telescopio sarà perfettamente in postazione equatoriale, con un errore inferiore al primo d'arco.
Effetti di una postazione scorretta
Un telescopio con la montatura non allineata con precisione al polo celeste insegue ugualmente gli oggetti celesti, che però tendono a spostarsi lentamente in direzione nord o sud, con velocità dipendente dall'entità dell'errore di postazione.
Se viene eseguita una fotografia in tali condizioni, e si eseguono correzioni in declinazione per tutta la durata della posa, si scoprirà che il campo inquadrato registra una rotazione di entità direttamente proporzionale alla durata della posa ed all'errore di postazione.
Le stelle al centro del campo risulteranno puntiformi ma quelle sui bordi saranno allungate in archi.
Testo originale a cura di Plinio Camaiti, membro della UAI e dell'Associazione Astronomica Milanese.
Trasposizione WWW a cura di Stefano Iacus (mc7414@mclink.it)
Vai alla HomePage di Astronomia.
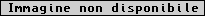 (figura X).
(figura X).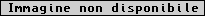 (figura X).
(figura X).